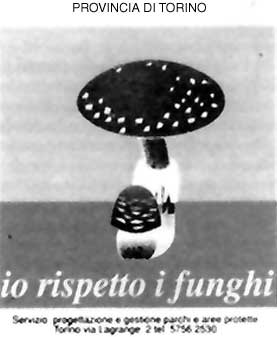Pierluigi Cornacchia
L'Amanita muscaria è molto diffusa in Italia, specie al nord, ma malgrado ciò e malgrado le popolazioni contadine conoscano il fungo da secoli, pochissimi etnologi e antropologi si sono dati la pena di raccogliere informazioni al proposito. Solo alcuni etnoiatri (studiosi di medicina popolare) hanno raccolto, come si vedrà, scarse notizie attorno agli avvelenamenti accidentali e ai rimedi popolari contro tale calamità.
Assolutamente nulla, invece, si trova sugli altri funghi allucinogeni che, come riferisce proprio questo libro, crescono anche in Italia.
Di fronte all'impossibilità di conoscere le abitudini popolari sull'uso dell'Amanita (specialmente su un eventuale uso voluttuario) si sono fate delle ricerche "sul campo", interrogando i vecchi e, talvolta, alcuni micologi dilettanti in diverse aree geografiche in cui fosse segnalata una qualche familiarità popolare con l'Amanita. Malgrado ciò e malgrado, come si vedrà, in varie regioni d'Italia l'Amanita fosse mangiata, gli italiani sembrano essere un popolo di quelli che Wasson indica come profondamente micofobi.
Nota con i nomi di:
- ovolo malefico, uovolacio, agarico moscarico, tignosa dorata (in italiano)
- cocch velenus, cocch bastard (nel dialetto milanese)
- bolè brut, bolè fauss (nel dialetto piemontese)
- ovol matt (nel dialetto bolognese)
- coco mato (nel dialetto veneto)
È testimoniato che nell'Ottocento, in Francia, l'Amanita muscaria era diffusamente consumata come alimento previa accurata preparazione che le toglieva le proprietà allucinogene. Secondo quanto confermano i micologi nostrani del XIX secolo, essa veniva analogamente usata anche nella penisola. Antonio Venturini, in due studi del 1842 e del 1856, conferma che l'Amanita era ben conosciuta dai nostri avi.
Nel lavoro del 1842 scriveva infatti: "Tutti i villici della riviera benacese e segnatamente quelli di Toscolano, di Maderno, di Gaino e di altre terre vicine, conoscono quanto quel fungo possa nuocere, se mangiato senza preparazione: ma non per questo essi lo temono, ché anzi lo vanno cercando e come fungo di conserva lo preferiscono a tutti gli altri".
A queste altre località, sulla base di ulteriori e precedenti studi si aggiunsero:
- provincia di Bergamo (Cima, 1826)
- Gabbiano (MN) e al Bosco Fontana (Bianchi, 1907)
- le Groane a Limbiate; nei corriletti in Lomellina, nel bosco Rotone di Pavia e anche nel bergamasco, ma assai di rado (Spadolini, 1890)
- ai Campi Flegrei presso Napoli, dove un contadino, secondo la testimonianza oculare di F. Cavara, ne raccoglieva per cibarsi regolarmente
- nei boschi e nelle conifere della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Canton Ticino, del Veneto, della Venezia Tridentina, delle Marche, della Toscana, del Lazio, della Campania e della Sicilia dove cresce copiosissimo (Bresadola, 1932).
F. Cavara (1897) confermava che in Vallombrosa (Firenze) l'Amaníta muscaria veniva comunemente consumata e affermava: "Posso assicurare, per relazione di molti, che in alcuni paesi di Toscana, per esempio sopra Pontassieve, nel tardo autunno questo agarico viene raccolto in quantità e messo a purgare in mastelli o bacinelle la cui acqua è rimutata ogni giorno, e ciò per 10 o 12 giorni, dopo di che viene ammannito alla stessa guisa degli altri funghi, mangiato e trovato eccellente. Occorre per ciò fare che la stagione sia fredda".
Tali informazioni sono state verificate direttamente sul campo. Nei paesi di Reggello, Saltino, Pian di Melosa e Vallombrosa sono state raccolte alcune testimonianze di anziani abitanti di quei luoghi. L'ovolo malefico, così lo chiamano correttamente da quelle parti, era abitualmente consumato dopo debite preparazioni (bollitura con aceto, conservazione sotto sale, spurgo con acqua corrente). Secondo le testimonianze, l'uso di cibarsi di questo fungo, durato fino all'inizio della 2'guerra mondiale, era dovuto unicamente a problemi di ordine economico.
Mentre venivano venduti sulla piazza di Firenze i funghi migliori e più buoni (i porcini per esempio), in proprio si consumava l'Amanita muscaria, perché non c'era altro.
Ma l'uso di questi funghi non ha mai dato problemi di ordine patologico, né tanto meno ha mai causato decessi. Un'anziana signora diceva di non aver mai sentito dire che l'uso del fungo avesse causato vomito, "torpore", ebbrezza o eccitazione mentale.
L'Amanita muscaría veniva raccolta in maggio e ottobre. Era conservata in "bigonce" (recipienti di legno di castagno) e messe a spurgare per 30-40-50 giorni. A.Venturi, nel suo lavoro del 1842, riferiva invece a proposito dell'uso che se ne faceva sul lago di Garda: "Nella nostra riviera si costuma far bollire l'agarico moscarico in un'abbondante quantità di acqua, e di metterlo dopo nella salamoja. Lo stesso si pratica in Russia e in Lapponia". Da tutto ciò sembra chiaro che l'Amanita muscaria, in Italia, è stata studiata solo sotto l'aspetto medico-farmacologico e botanico, mentre mancano studi di carattere sociologico e antropologico.
Sembra che in Liguria, nella zona delle Cinque Terre (località che per molto tempo è stata culturalmente e geograficamente isolata) i contadini usassero cibarsi dell'Amanita muscaria avendo la precauzione di togliere la pellicola rossa che ricopre il cappello. Anche nel bresciano sembra che si consumasse il fungo dopo averne "squamato" il cappello. E lo stesso sembra avvenisse nelle vallate bergamasche. Sull'uso alimentare e non voluttuario dell'Amanita, Paolo Mantegazza nel 1871 precisava: "Tra noi non si è mai studiata l'Amanita come sostanza inebriante, ma come veleno o come alimento; e le contraddizioni che si trovano nei diversi scrittori dimostrano la necessità che si ristudi più profondamente questa questione".
Malgrado tante e concordi testimonianze non è detto che l'Amanita muscaria, alla stessa stregua di altre droghe potenziali (belladonna, mandragora, stramonio, cicuta, ecc.) non possa essere stata usata in tempi a noi lontani anche a fini edonistíci.
I procedimenti empirici inventati dai nostri progenitori che permettevano un uso alimentare scevro da pericoli di avvelenamenti deve essere stato preceduto da un contatto con il fungo anche in una dimensione più ampia di quella semplicemente alimentare. Forse la mancanza di una salda "memoria collettiva" ha fatto sottovalutare e poi cancellato esperienze "irrazionali" di ricerca dell'estasi e oggi si possono solo fare delle supposizioni. In ogni caso, ritrovare le tracce di eventuali tentativi è un'impresa veramente ardua, se non impossibile.
Sulle esperienze contemporanee riferite nella letteratura micologica basti ciò che scrivono Arietti e Tomasi "della diretta quanto involontaria esperienza del professor Valerio Giacomini, proprio al termine dei suo internamento in un campo di prigionia in Germania durante l'ultimo conflitto. Approfittando di una certa libertà concessa dalle sopraggiunte truppe alleate, alcuni suoi soldati pensarono di integrare le ancor scarse razioni alimentari con un piatto di funghi raccolti nel vicino bosco, e come gli altri la sera ne mangiò anche il Giacomoni. Appena coricato, e senza alcun disturbo gastrico malgrado lo stato di denutrizione, accusò non sgradevoli sensazioni di ebbrezza e di esilarismo: gli fu subito palese che i funghi ingeriti appartenevano all'Amanita muscaria, ma da buon conoscitore dei suoi effetti nelle regioni del nord, non se ne preoccupò, e attese semplicemente di potersi liberare dei principi attivi attraverso la diuresi.
"Questa nostra tesi trova poi ulteriore conforto in uno scritto del dottor Teyro, apparso su La Domenica del Corriere, e richiamato dal noto micologo G. Ferri (1934) che lo commenta brevemente, riportando come segue le esperienze dell'articolista: "la scoperta non è mia; appartiene al dottor Gian Batista Grassi di Rovellasca, che, molti anni or sono, ha fatto degli esperimenti con questo fungo. La cosa mi ha tentato e, tempo fa, in una giornataccia di malumore, ho scacciato, con 20 grammi di agarico moscario fresco, ogni malinconia dalla mia mente, conquistandomi il più assoluto benessere, la più calma sensazione di voluttà, una grande limpidezza di pensiero e un'intensa volontà di lavorare, ciarlare, occupare mente e corpo. Una seconda volta ho aumentato la dose, una terza e una quarta ancora. Alla quarta volta, nello spazio di otto ore, ho preso circa 100 grammi (dico cento) di muscario fresco, e questa fiata l'effetto fu maggiore. Ho cantato, ballato, schiamazzato, riso; ho goduto di un'allegria pazza, sono stato felice.
Ne ho somministrato a parecchi amici e l'allegria di quelle ore in comune è superiore a qualsiasi descrizione. Il dottor Grassi racconta poi di aver guarito con una cura di agarico muscario, un individuo che si era dato a profonda malinconia con inclinazione al suicidio!".
"Dal,canto suo, il Ferri fa cenno nei termini seguenti di un caso cui si era interessato personalmente alcuni anni prima: "Si tratta di un falegname abitante a Milano, nei pressi di via Pietro Borsieri il quale nel pasto del mezzogiorno cu la consueta partita alle carte, assieme ad alcuni suoi compagni. A un tratto egli protestò perché qualcuna delle carte da giuoco gli era presentata completamente bianca (allucinazione muscarinica). Alle obbiezioni dei compagni egli diede subitamente in ismanie (delirio muscarinico), e distribuì qualche pugno ai suoi vicini; per cui venne da essi giudicato dapprima ubbriaco, poi impazzito. Ma chiamato d'urgenza un medico, mentre si discuteva sul da farsi, l'energumeno a poco a poco si tranquillizzò. Era cessata l'azione eccitante della muscarina sopra il suo cervello" (Arietti e Tomasi, 1969).
BIBLIOGRAFIA CITATA
Arietti N. & R. Tomasi, 1969, I funghi velenosi, Brescia, Museo Civico.
Bianchi G., 1907, Micologia della provincia di Mantova, cit.in Ferri G., 1934.
Bresadola G., 1932, Funghi mangerecci e velenosi, Trento, Museo Storia Naturale.
Cavara E, 1897, Funghi mangerecci e funghi velenosi, Milano, Hoepli.
Cima ES., 1826, Relazione e tavola sinottica dei funghi commestibili più comuni, cit. in Ferri, 1934.
Ferri G., 1934, Funghi velenosi sconosciuti o poco conosciuti, Pavia, Natura.
Mantegazza P, 1871, Quadri della natura umana, 2 voll., Milano.
Venturi A., 1842, Studi micologici, cit. in Ferri, 1934.
Venturi A., 1856, Avvelenamenti occorsi nell'autunno del 1855 in diversi paesi dell'Italia superiore per commestione di funghi. Pregiudizi che li occasionarono e modi di prevenirli, cit.in Ferri, 1934.
[Tratto da: Pierluigi Cornacchia, 1980, Notizie storiche e contemporanee sull'uso dei funghi psichedelici in Italia, in: P Cornacchia, I funghi magici, Milano, Editiemme, pp. 103-117.]