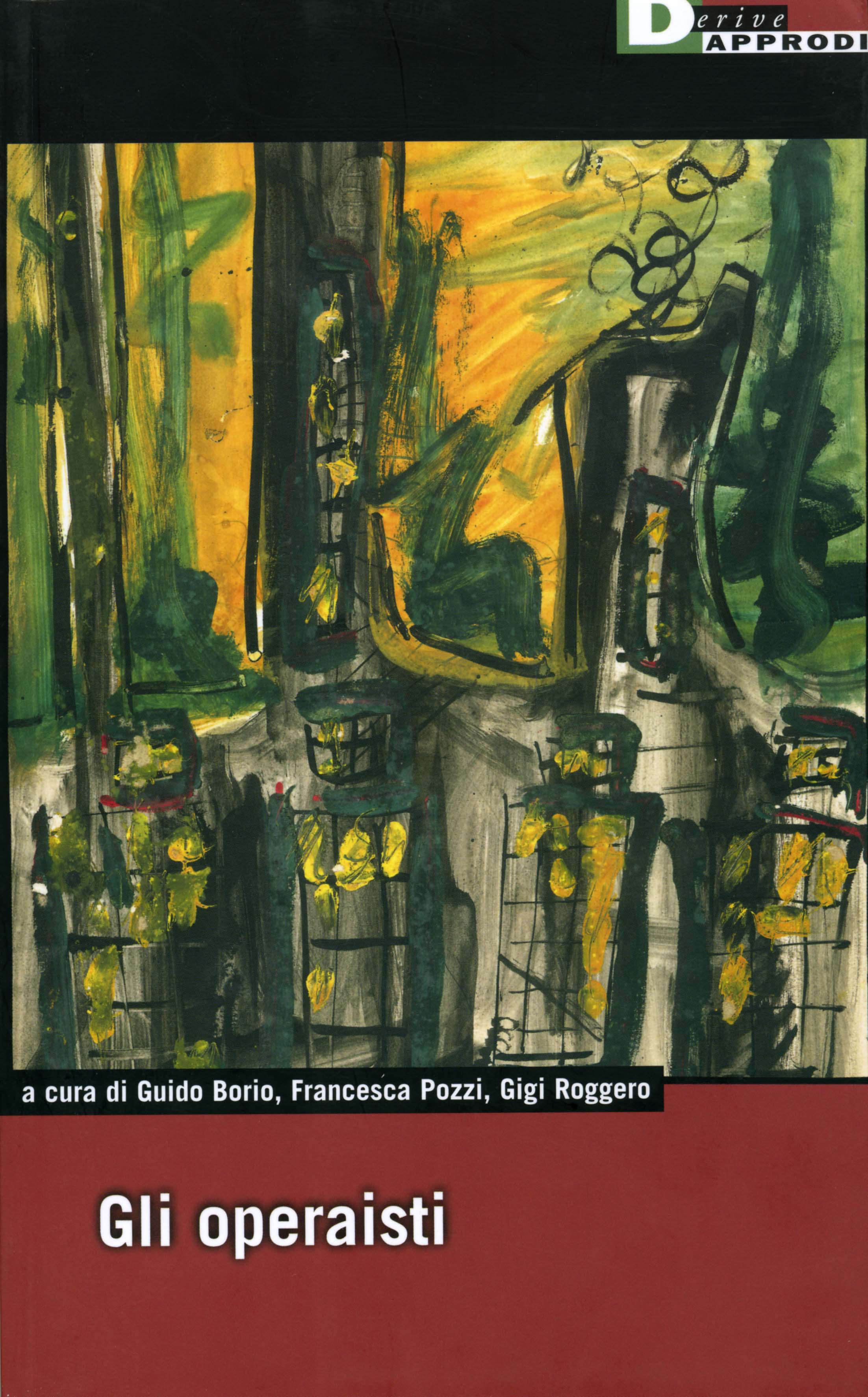 | Guido Borio, Francesca Pozzi, Gigi Roggero (a cura di), Gli operaisti, DeriveApprodi, Roma 2005
Parlando di operaismo non si fa riferimento a un corpus dottrinario omogeneo né a un unitario soggetto politico, ma a molteplici sentieri che hanno la propria radice in una comune matrice teorica, in un peculiare imprinting formativo, in un approccio incardinato sull'ambivalenza dei processi, in culture del conflitto e della trasformazione che - rileggendo il miglior Marx - sono estranee alla tradizione marxista, in filoni di ricerca pericolosamente sulla frontiera, in uno sguardo di parte sul mondo. Gli operai cessavano di essere un monumento da sacrificare al progresso umano e al futuro socialista, vittime predestinate e attori deboli da difendere, e divenivano potenza di parte che esprimeva rifiuto e liberazione. Lottavano per estinguere, e non per estendere, il proprio essere proletari, in quanto condizione di sfruttamento. L'etica del lavoro era finita.
La generazione che qui prende parola non è né ingenua né innocente, analizza ricchezze e limiti dei propri percorsi, non è né apologetica né pentita. Nell'arcipelago di percorsi che hanno punteggiato i movimenti degli anni Sessanta e Settanta, dentro la forza conflittuale e cooperativa che ha determinato una trasformazione profonda dei paradigmi produttivi e sociali, gli operaisti hanno così radicalmente messo a critica la cultura politica della sinistra. Perciò oggi, al di fuori di mitologie identitarie e impossibili continuità, rileggere quelle esperienze può non essere un semplice esercizio storiografico.
Il movimento globale e i conflitti del lavoro precario cominciano a parlarci della liberazione dagli anni Settanta: senza nostalgia per la condizione operaia e le garanzie del «fordismo», e al contempo avversi a ogni compromissoria apologia dell'esistente; senza più l'esigenza di guardarsi alle spalle per trovarvi le ragioni della propria identità, e però pronti a utilizzare ciò che è ancora vivo. Per costruire un pensiero critico radicale all'altezza dei tempi.
In Italia, alla fine degli anni Cinquanta, un ristretto gruppo di intellettuali e militanti politici di base inaugura, con la rivista «Quaderni rossi», un percorso di pensiero critico nei confronti dell'ortodossia marxista che segnerà in modo indelebile i destini dei movimenti sociali dei decenni successivi. Gli operaisti sono passati alla storia come gli autentici innovatori della politica come azione rivoluzionaria. I loro detrattori li hanno invece bollati come i «cattivi maestri», ispiratori di teorie e pratiche estremistiche, parti delle quali sarebbero sfociate nel terrorismo di fine anni Settanta. Delle tesi operaiste si sono cibate le lotte studentesche del '68 e quelle operaie dell'Autunno caldo del '69. Da esse hanno avuto origine i gruppi extraparlamentari più significativi come Potere operaio e Lotta continua, nuove forme di organizzazione sindacale, l'esperienza dell'Autonomia operaia, riviste, giornali, case editrici.
Il pensiero operaista ha conosciuto, al proprio interno, rotture, salti, discontinuità, ma ciò che l'ha sempre caratterizzato è il dimostrato metodo di analisi delle trasformazioni sociali. Quel pensiero e quel metodo esistono ancora oggi. Ne è prova l'influenza che sono riusciti a esercitare sui movimenti internazionali che si sono manifestati nel 1999 a Seattle. In questo libro «gli operaisti» si raccontano in prima persona, nella forma di autobiografie che compongono un viaggio straordinario in quei pensieri e in quelle azioni che furono ricerca di relazioni sociali più libere e democratiche.
Interviste con:
Romano Alquati, Alberto Asor Rosa, Nanni Balestrini, Bianca Beccalli, Franco Berardi (Bifo), Lapo Berti. Bruno Cartosio, Giairo Daghini, Mariarosa Dalla Costa, Mario Dalmaviva, Alisa Del Re, Rita Di Leo, Ferruccio Gambino, Romolo Gobbi, Mauro Gobbini, Claudio Greppi, Enrico Livraghi, Alberto Magnaghi, Christian Marazzi, Toni Negri, Franco Piperno, Vittorio Rieser, Emilio Soave, Mario Tronti, Paolo Virno, Lauso Zagato.
Guido Borio è nato a Torino nel 1954, lavora nel campo delle cooperative sociali.
Francesca Pozzi è nata a Como nel 1973, laureata in Scienze della Comunicazione, è ricercatrice sociale.
Gigi Roggero è nato a Casale Monferrato (AL) nel 1973, laureato in Storia Contemporanea, è dottorando presso I Università della Calabria.
|