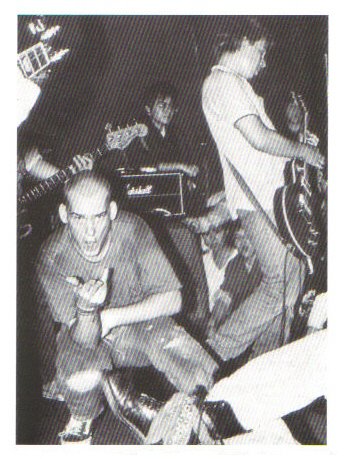
Capitolo Terzo
3.1 L’indagine empirica, il campionamento, la traccia di intervista
L’indagine empirica è stata svolta attraverso una ricerca all’interno della comunità più concretamente attiva nel campo della produzione DIY, ovvero le etichette indipendenti o autogestite, mediante la somministrazione di una traccia di intervista composta da 18 domande aperte, inviata per via telematica ai soggetti, selezionati per mezzo di un censimento preliminare, una sorta di campionamento a valanga, che ha permesso di individuare 64 etichette tra le più operative all’interno del panorama indipendente italiano. Su tale universo, 43 interviste sono state raccolte, con una caduta di 21 inviti. La traccia di intervista è stata inviata alle etichette all’inizio del maggio 2005, due volte si è proceduto a solleciti, sempre via e-mail, ai ritardatari. La raccolta definitiva delle interviste è avvenuta nella metà del mese di agosto 2005.
Il campionamento così effettuato ha messo a disposizione soggetti più o meno longevi, con diversi gradi di esperienza alle spalle, orientati prevalentemente su produzioni punk/hardcore, ma anche interessati a generi differenti e più sperimentali.
La traccia di intervista inviata è composta da 18 domande aperte, che consentono di lasciare spazio alle opinioni degli intervistati, riguardo la propria personale maniera di agire e vivere il DIY.
3.2 Un profilo degli intervistati
E’ difficile tracciare sinteticamente un profilo delle 43 persone che hanno deciso di collaborare all’indagine via mail, per cui dovremo limitarci, nel corso della nostra analisi, a descriverli attraverso il riferimento alle affinità e alle differenze esistenti.
La stragrande maggioranza delle etichette è gestite da una sola persona (53%, 23 etichette); una buona parte è gestita da un ristretto gruppo di persone che non supera i tre elementi (33%, 14 etichette); solo tre etichette consultate (il 7%) hanno all’interno quattro o cinque gestori ed altrettante sono composte da un nucleo superiore ai cinque elementi. Questi ultimi e rari casi di etichette condotte da oltre cinque persone corrispondono, sostanzialmente, ad etichette che esistono parallelamente ad altri progetti già avviati, gestite da una o più band o da un collettivo già formato, come, ad esempio, il caso di un collettivo di gestione di un centro sociale che decida di sostenere anche autoproduzioni. La scelta opposta di portare avanti singolarmente, o in compagnia di pochi elementi, un progetto DIY è, invece, dettata dalla scelta di una linea precisa e personale che non si intende condividere con altri, al fine di soddisfare appieno le aspettative di ogni singolo produttore.
I soggetti che hanno risposto alle domande, parlando di loro stessi senza fare riferimento ai propri soci, si sono equamente divisi in tre fasce di età: il 30% (13 soggetti) sono compresi tra i 20 ed i 25 anni, il 33% (14 soggetti) tra i 25 ed i 30 ed altrettanti (33%) oltre i 30 anni; solamente due persone, pari al 5% del campione, hanno meno di venti anni. Non risultano quindi particolari differenze quantitative tra le fasce, al punto di poter dire che i membri attivi all’interno del DIY in Italia sono sostanzialmente compresi in una gamma di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, in maniera equamente distribuita. Visto la giovane età anagrafica dei gestori delle etichette, e considerando le sempre costanti difficoltà che si incontrano in questo tipo di attività, può stupire constatare che il 12% delle etichette prese in considerazione sopravvivono oramai da oltre 10 anni (5 soggetti) e ben altre 9 (il 21%) sono operative già da almeno cinque anni; la maggior parte delle etichette (33%, 14), però, dichiara un’attività di tre o quattro anni, mentre 8, ovvero il 19%, hanno meno di tre anni di lavori all’attivo. Le restanti (16%) hanno dichiarato di essere nate nel corso di questo ultimo anno.
Il 70% degli intervistati ha dichiarato di occuparsi prevalentemente di coproduzioni, mentre il restante 30% preferisce la linea della produzione esclusiva utilizzando il proprio marchio, per ragioni di visibilità o di pieno controllo sul proprio operato. Solo il 19% (8 soggetti) delle etichette supera le cinque produzioni l’anno, mentre una sola riesce a sostenere dieci o più uscite all’anno. La maggior parte si assesta, invece, tra le tre e le cinque produzioni annue (ovvero il 42%, 18 intervistati) e ben il 37% (16 etichette) non riesce ad oltrepassare le tre produzioni l’anno. Nessuno dei 43 soggetti intervistati dichiara di riuscire a vivere completamente tramite le entrate dell’etichetta: molti la praticano come un’attività economica indipendente equivalente ad una semplice passione (consideriamo la posizione dei molti studenti, ad esempio), altri coprono le continue perdite dell’etichetta tramite le entrate del loro reale posto di lavoro, altri ancora si arrangiano con piccoli lavoretti saltuari o part-time per integrare. Nessuno degli intervistati ha dichiarato di mantenersi economicamente attraverso la gestione di un’etichetta DIY.
3.3 L’eterna illusione di una “scena”
In un circuito come quello del DIY e della musica indipendente vi è una forte componente a livello di presenza e apporto personale, che mette in risalto l’individualità del singolo a discapito di un’omologazione musicale e attitudinale, dando la precedenza al messaggio che si cerca di diffondere e all’attitudine del progetto delineata tramite la attività all’interno della “scena”. Ed è proprio sul significato e sull’uso della parola “scena” che occorre focalizzare meglio la nostra attenzione, visto che questo termine viene spesso e volentieri utilizzato solo per semplificare i discorsi, tentando di convogliare tutto quello che rappresenta un movimento, a livello di sfumature e diversità, all’interno di un’unica parola; appare molto più significativo parlare non tanto di un’unica scena, ma di diverse scene localizzate nelle varie zone della penisola e più o meno coese e coordinate in un unico movimento volto alla promozione della visibilità della controcultura DIY. Scene che si concretizzano nello svolgimento di diverse attività, dalla produzione di dischi o fanzine all’organizzazione di concerti o meeting, nel tentativo di creare diversi piccoli centri di sensibilizzazione controculturale fra loro comunicanti, attraverso le collaudate tattiche di scambi di date e di collaborazione tra gruppi. Certamente non tutte le zone della penisola godono da questo punto di vista delle stesse possibilità, ma non si tratta semplicemente di un problema di mezzi e strutture: ciò che probabilmente appare con maggior evidenza dalle interviste è proprio un problema di organizzazione e comunicazione. Vi sono città o province che al momento godono di spazi e buone possibilità di organizzazione, sia a livello interno (promozione e coordinamento delle band locali) che a livello esterno (opportunità di organizzare eventi di rilievo dove inserire gruppi provenienti da altre zone o dall’estero), ma non si può parlare di una rete coordinata e funzionale, in cui i singoli nodi sono in grado di interagire come si trattasse di un’unica realtà. Già attraverso precedenti storici come “Punkaminazione” si tentava la creazione di una sorta di rete interna di comunicazione in grado di riunire le varie realtà locali in un’unica scena capace di muoversi simultaneamente nel raggiungimento di obiettivi comuni, ma la situazione, come ci appare ora, è quella di una realtà in continuo divenire, dove ogni singolo elemento è in costante ricerca di contatti umani e sostegni ideologici per la propria attività nel tentativo di allargare il proprio raggio d’azione. Eccezioni di rilievo che annullano occasionalmente questo senso di precaria ed instabile unità possono essere considerati i grandi festival DIY (interviste 5, 6 e 11), per fortuna sempre più frequenti ed affollati, che vengono organizzati come una sorta di meeting/concerto dove tutti possono incontrarsi, confrontarsi, scambiare materiale nuovo ed assistere alle performance di tante band che altrimenti sarebbe difficile vedere in separati contesti: tali eventi sono un asso nella manica per la creazione, per quanto sfuggevole, di una scena in grado di riconoscersi e supportarsi su vasta scala. I contatti epistolari o interattivi vengono sostituiti in queste occasioni con interazioni personali che regalano un volto a chi è sempre e solo stato un nome ed un indirizzo, favorendo l’incrementarsi di fiducia e stima reciproca; molte persone sono stimolate ad intraprendere lunghi viaggi per partecipare ai meeting, consce dell’importanza che tutto ciò può avere nell’obbiettivo di una crescita sia personale che comune. L’illusione, appunto, di una scena. Le tante facce, le tante sfumature dello stesso fenomeno convergono in un unico spazio, con la convinzione sempre maggiore che tante piccole forze unite costruiscono una potenza, e dal confronto tra esse si può sviluppare una via per crescere assieme.
Se tante piccole realtà isolate non sono al momento in grado di formare un’unica scena, comunque consentono la progressione della diffusione di un messaggio controculturale che davanti al monopolio attuale del music business e dei suoi meccanismi di mercato appare come una sempre più tenace forma di resistenza, ed appaiono in continua ricerca di supporto reciproco e collaborazione per portare avanti la propria piccola grande lotta.
3.4 Etica DIY e margini di libertà
Sono in molti ad essere convinti che la cultura Do It Yourself costituisca una scelta consapevole che comporta l’accettazione di determinati valori intrinseci, ma occorre distinguere tra la scelta etica di agire ai margini del mercato musicale nel circuito indipendente, e quella di dimensioni più vaste, che consiste nel rifiuto delle distribuzioni commerciali, della promozione su stampa o su siti specializzati e dell’appoggio di agenzie di booking per i concerti. L’esperienza ci mostra come spesso non ci sia via d’uscita per una piccola etichetta autogestita, a meno di scendere a compromessi con circuiti che, pur dichiarandosi indipendenti, con il no-profit hanno ben poco a che vedere. Alcune etichette indipendenti operano come delle piccole majors, seguendo alla lettera i precetti del marketing al fine di enfatizzare la promozione del proprio operato (in 9 casi le interviste rilevano preoccupazioni a questo riguardo). Spesso esse restano indipendenti solo in quanto gestiscono un minore flusso economico e finanziario di quello posseduto da una major, senza tuttavia mostrare grosse differenze attitudinali.
Se, allora, come etica DIY ci limitiamo a considerare, tralasciando il modus operandi di ogni singola etichetta, la semplice scelta fatta di inserirsi in una ristretta e marginale fascia di mercato che si allontana dalle pressioni e dal grande giro economico del music business, allora appaiono con evidenza tratti comuni che rappresentano la base di questa filosofia controculturale, caratteristiche ampiamente considerate e trattate dalle etichette intervistate attraverso i questionari sottoposti.
Un denominatore comune è la decisione dell’etichetta di mantenere una linea artistica ed economica quanto più indipendente possibile e fedele alla propria attitudine ideologica e musicale, scelta volta alla ricerca del pieno soddisfacimento del proprio operato e della gratificazione dettata da una coerenza qualitativa delle uscite. Per questo motivo esse cercano di mantenersi il più lontano possibile dalle leggi del mercato, che prediligono la scelta di artisti potenzialmente più redditizi nei confronti di chi oppone la qualità artistica all’esasperata ricerca di affermazione. Si può inserire in questo discorso l’aspetto relativo alla trasmissione di contenuti politico-sociali attraverso l’arte e la musica indipendente. Musica non significa solo intrattenimento: essa può essere poesia, può essere arte o può essere lotta, comunque, indistintamente dalla sua forma, deve avere un contenuto, e questo deriva certamente dagli ambienti in cui un determinato fenomeno musicale è nato e si è sviluppato.
In Italia sono stati i centri sociali i primi ambienti a dar spazio ad un certo tipo di espressione che si opponeva agli stereotipi commerciali della musica concepita solo per vendere e guadagnare: la lotta politica e la resistenza ideologica innescata negli ambienti occupati ed autogestiti d’Italia corre sugli stessi binari della resistenza musicale condotta da chi teme l’omologazione artistica come impoverimento culturale. E’ questa la filosofia del dare voce a chi non ha voce ma tanto da dire. A dimostrazione dell’attaccamento al contenuto della proposta musicale, 6 etichette ci hanno fatto notare, in maniera più o meno esplicita, il loro prendere le distanze da band che trasmettono messaggi di stampo razzista, fascista, sessista od omofobo.
3.5 Un passo indietro rispetto all’esperienza europea?
Il nostro questionario, tra le altre cose, ci offre informazioni utili per mettere a confronto la situazione del circuito underground DIY in Italia con quello sviluppatosi in altre nazioni europee. In modo preliminare occorre ricordare come in ogni paese il panorama controculturale abbia avuto una propria crescita e proprie peculiarità, ovviamente legate alla sua specifica storia politica, sociale ed economica più recente. Noi semplicemente ci limiteremo a considerare quelle che sono le maggiori differenze esistenti attualmente tra la nostra realtà e quella dell’Europa del nord e dell’Europa dell’est.
Le divergenze si riassumono principalmente in termini di organizzazione e strutture, non in termini di qualità musicale. Tra i maggiori problemi dello sviluppo della scena nazionale, quelli che sono risultati essere i più limitanti e scoraggianti per le etichette e per le band sono quelli relativi alle tradizionali barriere burocratiche, rappresentate da società ostili come SIAE o ENPALS, che mettono i bastoni tra le ruote continuamente ai piccoli produttori o promotori di iniziative senza interessi di lucro: ciò è evidenziato da ben 10 soggetti tra gli intervistati. Altri danno maggior rilievo al disinteresse governativo nel dare spazio alla promozione di certe forme di espressione artistica popolare, diversamente da quanto avviene in altri stati nord europei. Di questo aspetto ci parlano diverse etichette, ad esempio 8mm, che nel suo confrontarsi con altre realtà racconta: “Ho conoscenti in Germania, Belgio, Olanda, Svezia, Francia che ricevono sussidi statali per la loro attività di label manager o musicisti. Hanno accesso con disinvoltura alla programmazione di gallerie d’arte contemporanea, centri culturali, più semplicemente viene riconosciuto loro il fatto di produrre della cultura. Questo permette di lavorare con disinvoltura, di operare su eventi e prodotti con una serenità di fondo che indubbiamente influisce sia sulla quantità che sulla qualità dei risultati. In Italia produrre musica fuori dalle logiche aziendali è considerato ancora in maniera diffidente, come un’attività di tipo amatoriale, dilettantistico. Finché le nuove idee saranno prese in considerazione in questo modo non vedo grossi margini di miglioramento per le cose nel nostro paese.” (intervista 1); similmente Bar La Muerte, nel suo mantenere fitte relazioni con le realtà estere, sottolinea le differenze soffermandosi sul concetto di Welfare: “L’Italia ha avuto uno sviluppo minore per motivi sociali: nei paesi con un sistema di welfare è molto più semplice per i giovani lanciarsi in carriere musicali, giocarsi il tutto per tutto, perché ci sono nazioni dove lo studente che vive da solo riceve soldi per affitto e sopravvivenza, o altre dove i sussidi di disoccupazione funzionano bene ed in modo compatibile con la carriera musicale, o paradisi come la Francia, dove basta provare di aver suonato un certo numero di concerti nel corso dell'anno per avere un sussidio da musicista e persino garanzie pensionistiche. Chiaro che in questi paesi si può rischiare di più, perché si hanno le spalle coperte. Invece in Italia: 1) non ci sono soldi pubblici su cui contare; 2) c'è poco lavoro, quindi una volta ottenutone uno si tende a mollare ogni altra velleità ed a considerare la musica solo come un hobby o un sogno; 3) gli affitti sono altissimi e si esce troppo tardi dall'università, con la conseguenza che si esce tardi di casa, e quindi quando arrivi a 27-28 anni vuoi solo trovare un lavoro che ti dia la sicurezza di poterti pagare l'affitto e uscire di casa. In tutto questo c'è poco posto per la musica.” (intervista 2). Soprattutto all’atto pratico, come emerge da quasi tutti gli intervistati, una band proveniente dall’Italia che vuole proporre la propria musica senza limitazioni di estensione deve contare solo sulle sue proprie forze; differentemente, si possono elencare infiniti esempi di band estere finanziate e supportate nei loro tour europei dai loro stessi governi, come nell’esempio che ci racconta Smartz: “Prendi il caso dei Children Of Fall, band hardcore svedese di passaggio qualche tempo fa in Italia (e spesso e volentieri in tour): raccontavano di potersi permettere di girare così tanto perché lo stato svedese riconosceva loro delle sovvenzioni. Perché facevano “cultura”, e la esportavano fuori dal loro paese... Ecco, cose del genere da noi sono impensabili.” (intervista 37). Inoltre, anche a livello interno le limitazioni sono considerevoli: oltre ai centri sociali difficilmente altri luoghi danno la loro disponibilità a sostenere concerti DIY, mentre nella zona nordeuropea anche locali e pub spesso si prestano a questi eventi.
A proposito, invece, dell’esterofilia dell’ascoltatore italiano, Loudblast ci fa notare che: “Nel mercato discografico italiano l'89% dei dischi che si vendono sono major, una percentuale unica in Europa. In quell'11% c'è troppo poco spazio per tutto il resto.” (intervista 21); Rebound Action (intervista 30) sottolinea, invece, come, qualsiasi sia il genere musicale che si prenda in considerazione, appena il 40% delle band che sostengono tour europei decidono di passare anche per l’Italia.
Altre cause sono riportate per motivare l’arretratezza del circuito DIY italiano: alcune etichette fanno riferimento alla forte cultura ecclesiastica da sempre presente nella nostra nazione (intervista 9), alla mancanza di politicizzazione del circuito, che va così a perdere in coesione (intervista 12), alla limitatezza numerica di persone che abbiano scelto il DIY come scelta di vita, impostando la loro esistenza sul rispetto dell’etica “fai da te” (intervista 34).
3.6 Internet: supporto o freno per il DIY?
Da quanto emerso dalla nostra indagine, le evoluzioni tecnologiche nel mondo delle comunicazioni hanno fortemente influenzato il modo di instaurare e far crescere i rapporti: prima fra queste internet, la cui diffusione ha inevitabilmente segnato il circuito DIY. Internet ha reso più rapida ed efficace la comunicazione, rendendola accessibile ad un ampio numero di utenti: un vantaggio che chiaramente non può non essere riscontrato dalla gran parte delle etichette intervistate, che riconoscono pressoché all’unanimità il valore di questo mezzo, se utilizzato con consapevolezza. La vastità di contenuti, informazioni e materiale audio/video reperibili in rete ne fa una vetrina di grande prestigio e potenzialità infinite, ma, come tutti i mezzi comunicativi, può rivelarsi un’arma a doppio taglio nel momento in cui se ne trascendano le funzioni primarie o se ne esageri l’uso.
Ad esempio, se da una parte internet è un ottimo canale dove piccole comunità sottoculturali possono ritrovarsi ed interagire in luoghi virtuali interamente dedicati a loro, dall’altra può creare l’illusione di un senso di appartenenza ad un movimento che si presenta in rete molto più vasto di quello che è nella realtà; questa teoria è sostenuta, tra le altre, anche da Nothing City, etichetta che occupandosi anche della gestione di un piccolo squat (centro sociale) nel centro di Bologna (Atlantide) ha la possibilità di confrontarsi direttamente con realtà provenienti da tutta la nazione e molto spesso anche dall’estero: “Il sapersi vendere su internet vuol dire molto e sicuramente le grosse case discografiche riescono a farlo benissimo e con mezzi molto più potenti dei nostri. Ho la sensazione che internet, e con internet intendo forum, messageboards e simili, faccia sembrare il mondo del DIY molto più vasto di quello che è. Osservando da cinque anni le persone che vengono ad Atlantide mi sono accorto che sono sempre più o meno le stesse, non credo che siano tante quelle che hanno trovato Atlantide o che comunque si sono avvicinate alla scena grazie ad internet. Per uno che muove i primi passi è più utile un contatto fisico, poi ci si può buttare nel mondo vuoto di internet, ma prima bisogna imparare a discriminare le cose con la propria testa partecipando attivamente nella scena. La scena non vive grazie ad internet, senza questo viveva benissimo lo stesso!” (intervista 26). Diversamente Full Blast, etichetta salentina, si dichiara entusiasta delle possibilità di arginare gli ostacoli geografici e morfologici attraverso internet, arrivando a pensare che proprio attraverso la rete si possa creare un unico fronte musicale che remi in direzione contraria al music business, mettendo in evidenza tutte le sue potenzialità: “Internet è il nostro mercato!!! Grazie alla rete gli abbiamo soppiantato tutte le majors del mondo. Pensa al circuito indipendente come un unico essere, remiamo anche involontariamente tutti dalla stessa parte, e questo grazie a internet. Prima solo con grandi investimenti pubblicitari si raggiungevano milioni di giovani consumatori, e questo solo le majors potevano farlo, ora è alla portata di tutti, anche per chi vendeva una volta pentole porta a porta!” (intervista 16).
Tuttavia, non tutti condividono questo entusiasmo, esistendo anche un'altra faccia della medaglia dai risvolti piuttosto preoccupanti, ben evidenziata dal 33% dei soggetti intervistati: la freddezza di questo mezzo e l’inevitabile spersonalizzazione derivante dal celarsi dietro un computer racchiudono più controindicazioni di quelle a prima vista osservabili. Oltre alla progressiva eliminazione di un contatto fisico diretto con la scena ed i suoi meccanismi, sostituito da un approccio distante e virtuale, la mania del download e della visibilità in rete conduce a paradossi a volte inesplicabili: la possibilità di venire in possesso di una grande mole di produzione musicale, resa possibile dalla digitalizzazione della musica, porta ad un sovraccarico di materiale, di cui l’utente non usufruirà mai. Il downloading dei brani in rete ha, inoltre, oltrepassato qualsiasi senso etico di supporto alla causa DIY: un conto è scaricare dischi usciti su major ed impossibili da reperire a cifre razionali (si tratta di album che nei negozi costano mediamente a 20 euro!), un conto è scaricare in continuazione dischi di band DIY che in realtà vendono i loro prodotti originali a cifre ragionevoli e senza fini di lucro, fedeli alla politica dell’autofinanziamento. Questo porta conseguenze inevitabili per i banchetti delle distribuzioni, veri e propri bazar di questa forma di controcultura, presenti ad ogni concerto e sempre meno affollati: 11 etichette si sono lamentate dei danni derivanti dalla pratica del downloading al meccanismo dell’autofinanziamento e della copertura economica delle produzioni. Infine un ultimo accenno al contenuto stesso della musica digitale ed alla sua forma: scaricare interi dischi in rete, seppur messi a volte a disposizione dalle stesse etichette a fine non commerciale, pregiudica quel contatto fisico con il prodotto, che è, in un certo senso, indispensabile per una sua completa comprensione e fruizione.
Per quanto riguarda le varie forme di fruizione del web, si è già parlato delle perplessità che suscitano le webzine per il loro essere omologate ed autoreferenziali, perdendo il punto di vista critico e personale che contraddistingueva invece le progenitrici fanzine. Altre critiche sono indirizzate alle messageboards, ovvero luoghi virtuali dove cerchie di persone unite da una comune passione si ritrovano protette da nomi da loro scelti, che nascondono le vere identità. Questa possibilità dà luogo, in molti casi, a vere e proprie espressioni di arroganza e prepotenza, che sfociano spesso in insulti gratuiti. Infine i blog, diari personali on line, vengono principalmente visti come uno sfogo. Nell’opinione di gran parte degli intervistati sono considerati utili solo quei pochi che esistono in sostituzione di un vero sito internet, e che danno informazioni su progetti DIY.
3.7 Le tante facce del movimento
Tracciare i tratti fondamentali che differenziano le diverse correnti di pensiero interne alle controculture subordinate alla filosofia punk può risultare estremamente utile al fine di una corretta interpretazione dei questionari raccolti. Specularmente alle differenze ideologiche vi sono anche delle differenze materiali dalla forte valenza semiotica. Si è già visto quello che è stato il punk e come abbia rivoluzionato attraverso le sue provocazioni musica e costume, si è parlato anche di hardcore, non solo come estremizzazione sonora del punk, ma anche come presa di coscienza e consapevolezza dell’importanza di una visione critica del mondo, lontana dallo sfrenato nichilismo punk; ammesso che ai giorni nostri sia rimasto ancora vivo qualcosa del significato originario di queste correnti madri, appare tuttavia limitante non citare altre controculture fortemente interrelate a queste.
Nata da una costola dell’hardcore, lo straight edge (in italiano “linea diritta”), termine spesso citato nel corso delle nostre interviste, “fa riferimento ad una filosofia che si basa sul più importante dei principi riguardante l’approvazione di una tipica vita indipendente da qualsiasi tipo di droghe, in cui ognuno ha il diritto di decidere liberamente per se stesso. Si sviluppò come effetto della scena punk/hardcore dei primi anni ottanta. Il termine fu creato da Ian Mckaye, nella canzone che prende il nome dal titolo dell’album, mentre egli era il cantante del gruppo hardcore Minor Threat, dalle notevoli capacità produttive. Mckaye si allontanò dalla tendenza nichilista del punk rock, promuovendo invece la semplice (molto semplice) filosofia del “non bere, non fumare, non fare sesso promiscuo e casuale”. A dodici anni dallo scioglimento dei Minor Threat, queste semplici credenze hanno trasformato le menti di milioni di adolescenti in tutto il mondo. Sempre più disprezzato in malo modo dalla comunità, giovani uomini e giovani donne adottano la dottrina dello straight edge come un metodo per migliorare prima loro stessi e, poi, il mondo in cui vivono. Mentre l’originale definizione dello straight edge includeva solo il rifiuto della mente condizionata da sostanze e del sesso promiscuo, le moderne interpretazioni comprendono la dieta vegetariana e l’ampliamento dell’importanza della consapevolezza di protezione dell’ambiente e delle questioni politiche, così rendendo la definizione sempre più complicata” (Luca Frazzi, 2003, p.51, realizzato grazie al contributo di Davide, chitarrista della straight edge band bolognese Summer League).
Il rigetto spontaneo e audace dei giovani Minor Threat nei confronti di tutte quelle figure del mondo punk che, per via dei propri eccessi, risultavano vicine nell’immaginario comune alla rockstar maledetta, bruciata da droghe e alcool, si ritrova con evidenza nei testi scritti dal frontman Ian Mckaye. La canzone che da il nome al movimento, appunto intitolata “Straight Edge” (1981), recita: “Sono una persona come te ma ho cose migliori da fare che sedermi a fumare droghe / so che posso riuscirci (…) non voglio aver bisogno di usare una stampella / ho preso la linea diritta.”; il concetto viene ribadito anche nel testo del pezzo “In My Eyes” (1981): “Mi dici che ti piace il sapore / hai solo bisogno di una scusa / mi dici che ti calma i nervi / hai solo bisogno di sentirti figo / (…) mi dici che io non faccio la differenza / almeno io ci sto provando / tu cosa stai facendo?”. I Minor Threat riuscirono davvero a fare la differenza, dando vita ad un nuovo tipo di approccio coerente e positivo dalla portata rivoluzionaria; tutto ciò incidendo nella loro breve storia appena quattro singoli, tutti autoprodotti per la loro stessa etichetta, la Dischord, per un totale di appena quaranta minuti di musica.
Un’altra corrente non semplice da descrivere unitariamente è quella skinhead (in italiano “teste rasate”), per le diversissime sfumature presenti al suo interno: per esempio, gli skin oggi possono essere tanto apolitici, quanto redskin (militanti di sinistra), o bonehead (naziskin, militanti di destra). La filosofia skinhead è radicata negli ambienti delle strade e dei quartieri periferici, nascendo proprio come figlia della working class nelle periferie est londinesi (la zona chiamata East End) attorno al 1969: la rappresentazione rude, violenta e stradaiola di questa particolare controcultura si riflette nell’ aspetto estetico che la caratterizza, accentuandone la derivazione proletaria. Nel corso degli anni questo movimento è cambiato notevolmente, arrivando ad assumere forti connotazioni politiche, e facendo sentire la propria presenza anche all’interno degli ambienti degli stadi di calcio e delle tifoserie. Musicalmente, esteticamente e ideologicamente il movimento è legato alla musica Oi!, termine coniato dal giornalista e critico musicale Gary Bushel nel 1981, derivante dall’espressione “Hey you!” pronunciata nel dialetto cockney londinese: si tratta di un punk molto politicizzato che in Italia ha da sempre discreto seguito, grazie anche alla presenza nella nostra nazione di grandi band Oi! che sono state in grado di fare storia, come Nabat, Klasse Kriminale o Rough. Roddy Moreno, cantante degli Oppressed, gruppo di punta del primo Oi! inglese, fu anche fondatore di una delle più seguite correnti skinhead dei nostri giorni: il movimento antirazzista SHARP (Skinhead Against Racial Prejudice). A livello di contenuti l’Oi! si concentra su un populismo ed una retorica della working class, sull’odio istintivo per forze dell’ordine, politicanti, hippy e giornalisti, sul senso del territorio, sulla fierezza e sullo spirito di gruppo.
Un’altra creazione spontanea del punk è il crust, termine legato ad una musica velocissima e rumorosa, compressa in canzoni cortissime e contornate da testi che assomigliano a vere e proprie denunce sociali. La classe e la finezza compositiva lasciano spazio ad un’urgenza espressiva caotica ed aggressiva, l’estremizzazione della musica votata alla distruzione di se stessa (come usavano dire i Wretched, band milanese del circuito del Virus: “Rumore, non musica!”). Tra le argomentazioni sostenute da questa musica, la preminenza di tematiche sociali ed ambientali sottintende una militanza, o comunque un essere concerned, termine anglosassone utilizzato da Noam Chomsky nell’accezione di “sentirsi riguardato dagli avvenimenti del mondo ed esserne insieme preoccupato” (Noam Chomsky, 2005, p.163): questo senso di responsabilità ci introduce nel vasto campo dell’attivismo, pratica spesso supportata da filosofie fortemente “concerned” come quella crust o straight edge.
Prerogativa di base dell’attivismo è il sostegno ad un ideale attraverso la pratica dell’azione diretta, volta a modificare il corso delle cose, sia questo ideale l’animalismo, la lotta contro la cementificazione delle aree naturali o semplicemente il diritto ad una dimora, come nel caso degli occupanti di case di cui si è parlato in precedenza. Una breve carrellata tra le più note organizzazioni attiviste esistenti ci può far intuire quanto vasto sia il loro raggio d’azione: Animal Liberation Front (ALF), per esempio, non si batte affinché gli animali abbiano gabbie un po’ più ampie, ma nessuna gabbia, nessun prezzo e nessun padrone che ne disponga a piacimento, volendo per gli animali ciò che una persona vorrebbe per se stessa: la libertà di vivere secondo la propria inclinazione. Perseguendo questo ideale, Animal Liberation Front agisce attraverso sabotaggi a laboratori di vivisezione animale e liberazioni di animali ingabbiati.
Tra le azioni volte alla rivendicazione di spazi sicuri per l’essere umano contro il pericolo e l’inquinamento dell’automobile, vi sono quelle di Critical Mass, che consistono in un disturbo del traffico urbano, attuato in bicicletta; similmente Reclaim the Streets o Road Alert organizzano free party radunando migliaia di persone nei cantieri per la costruzione di nuove strade o autostrade, con il preciso intento di fermarne l’attività: spesso la pratica di questi gruppi si estende anche all’occupazione di boschi e aree verdi per proteggerli dalla distruzione causata dall’avanzare del progresso.
Per finire, occorre citare un altro noto collettivo nato nel 1980 negli Stati Uniti, Earth First!, che diede grande ispirazione anche alla nascita di alcune comuni (come le già citate Donga Tribe) basate sulla teoria del biocentrismo, concetto derivato dal norvegese Arne Naess, che per primo nel 1972 coniò il termine di ecologia profonda: al centro delle preoccupazioni nei confronti del degrado ambientale viene messa la natura stessa, e non più il solo essere umano.
Occorre ancora una volta ribadire che tutte queste sintetiche nozioni, che rappresentano più un glossario che una vera e propria traccia di analisi, sono state introdotte per far meglio comprendere ed inserire in un contesto le risposte date dai soggetti intervistati.
Ora è finalmente arrivato il loro turno.
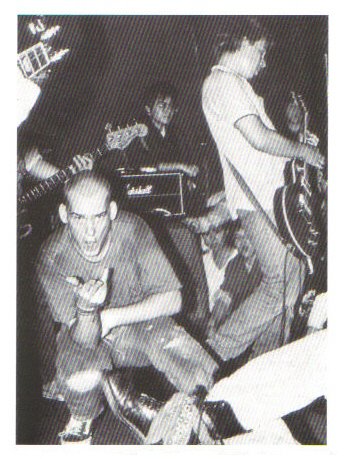
Immagine 11 - I Minor Threat, il gruppo che coniò il termine straight edge e si fece portavoce di questa nuova filosofia nel mondo.